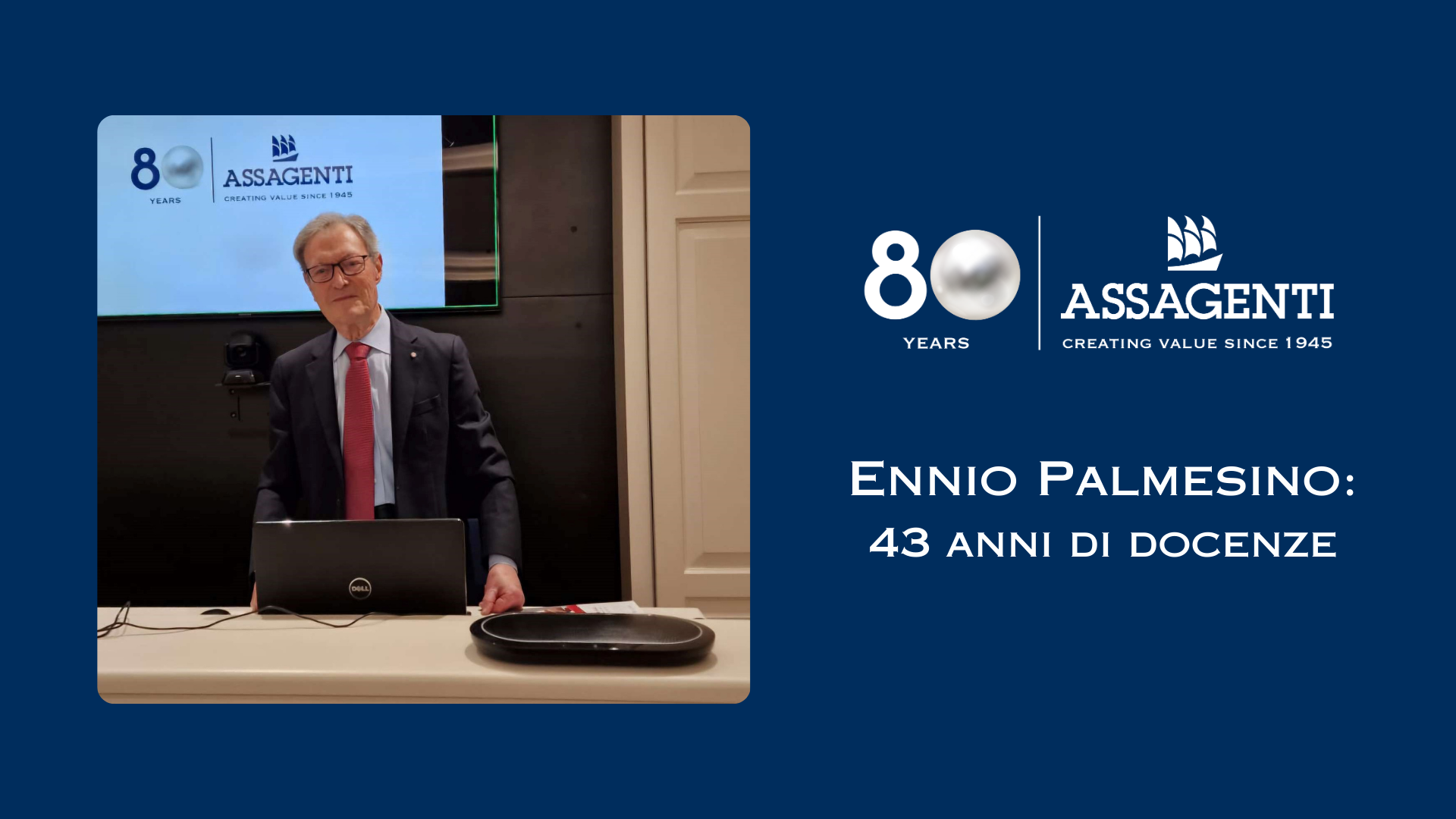Nuovi emendamenti alla Convenzione FAL: semplificazione, misure sanitarie e lotta alla corruzione
.png)
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
A partire dall’1 gennaio 2024 entreranno in vigore nuove modifiche alla Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (“FAL”) del 1965 (ma entrata in vigore nel 1967), che disciplina gli adempimenti formali che riguardano le navi che fanno scalo nei porti degli Stati che l’hanno adottata.
La Convenzione, ratificata
dall’Italia nel 1972, opera ormai da più di 55 anni e viene periodicamente
aggiornata dal FAL Committee dell’International Maritime Organization (IMO) al
fine di garantire una sempre maggiore uniformità delle norme, prassi e suggerimenti
che disciplinano i requisiti documentali e le procedure di arrivo, stazionamento
e partenza delle navi, per esempio attraverso l’uso di una documentazione
standardizzata (i cosiddetti “Formulari FAL” o “FAL Forms”).
Gli emendamenti alla Convenzione sono
stati approvati dal Facilitation Committee dell’IMO nel corso della 46esima
sessione (tenutasi dal 9 al 13 maggio 2022) e sono contenuti all’Allegato I del
report finale del Committee.
Le modifiche hanno tre obiettivi principali.
In primo luogo, una semplificazione delle formalità cui devono sottostare gli armatori che intendono fare scalo nei porti degli Stati parte alla Convenzione. A tal fine, è previsto che le autorità statali debbano necessariamente predisporre un sistema a sportello unico (cosiddetto “single window (SW) system”) per tutte le operazioni che rientrano nell’ambito applicativo della Convenzione, il quale dovrà peraltro garantire il carattere confidenziale delle informazioni trattate. Lo stesso Committee ha predisposto delle linee guida relative alla creazione al funzionamento dello sportello unico.
Tale sistema è peraltro accompagnato da una semplificazione della modulistica, che è stata standardizzata per garantire che le navi possano muoversi nei porti degli Stati contraenti utilizzando sempre gli stessi documenti, con una evidente diminuzione delle formalità richieste. In particolare è stato previsto che le autorità non possano richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli previsti alla sezione 2 dell’emendamento (alcuni dei quali richiesti da altre Convenzioni internazionali); si noti peraltro che tutti i riferimenti a tale modulistica sono da intendersi come in formato elettronico, dal momento che con le modifiche da ultimo introdotte sono stati eliminati tutti i riferimenti alla documentazione in formato cartaceo.
Secondariamente, sono state introdotte una serie di misure in risposta a potenziali crisi sanitarie, sulla base dei problemi verificatisi con la recente pandemia da Covid-19. L’adozione delle stesse mira infatti a far sì che, anche qualora una situazione del genere si dovesse ripetere, il traffico marittimo nei porti non ne esca totalmente compromesso o che comunque subisca danni limitati. In quest’ottica, viene per esempio richiesto alle autorità nazionali di consentire alle navi e ai porti di rimanere pienamente operativi durante un'emergenza sanitaria, con il dichiarato obiettivo di preservare il traffico di merci globale. Ancora, sono state emanate delle linee guida (c.d. “best practices recommendations”) che riportano misure atte a garantire, anche in caso di emergenza sanitaria, il rapido e corretto rimpatrio dei lavoratori marittimi.
Un’ultima previsione in materia
sanitaria riguarda infine il trasporto di passeggeri, e richiede alle autorità
nazionali di informare questi ultimi sull'obbligo di vaccinazione con un
anticipo sufficiente rispetto alla partenza (al fine di permettere loro di
adeguarsi a eventuali modifiche). È inoltre incoraggiato l’uso, da parte
della autorità sanitarie, del Certificato Internazionale di Vaccinazione o
Profilassi (ossia un certificato vaccinale multilingue creato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) in modo da garantire una maggiore
uniformità nell’utilizzazione e accettazione dello stesso.
Una terza serie di misure mira
invece a contrastare il fenomeno della corruzione nel settore marittimo, con
specifico riferimento alle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero
riverberarsi sul sistema portuale.
Secondo il Committee il fenomeno
potrebbe essere descritto come “l’accettare, dare, promettere o agire in
qualsiasi modo che potrebbe essere interpretato come un tentativo di
influenzare impropriamente le persone ovvero le decisioni relative alle operazioni
navali/portuali”.
Come evidenziato dal Committee,
la corruzione ha un impatto significativo sulla speditezza ed efficienza delle
attività portuali: alla luce di ciò, viene pertanto richiesto alle autorità
nazionali di adottare un approccio più attivo nel contrasto alla stessa, per
esempio attraverso un maggior coordinamento sia interno (tra le diverse
autorità statali) che a livello internazionale (tra autorità di Paesi diversi).
La lotta al fenomeno corruttivo non dovrà in ogni caso comportare un pregiudizio per i dati personali dei soggetti coinvolti: è infatti previsto che, nel caso in cui le autorità e le altre parti interessate abbiano accesso a informazioni commerciali sensibili, queste debbano in ogni caso essere trattate in modo confidenziale.
Come chiarito dalla Commissione europea, le modifiche rappresentano un tentativo di avvicinamento della disciplina prevista dalla Convenzione FAL con i requisiti già indicati dal Regolamento (UE) 2019/1239 – anch’esso teso all’introduzione di un “sistema di interfaccia unica marittima europea” (“European Maritime Single Window environment”) che dovrebbe trovare applicazione a partire dal 15 agosto 2025 – e devono pertanto essere viste di buon occhio nell’ottica di una sempre maggiore armonizzazione delle procedure e prassi internazionalmente applicabili.